 La serie Netflix Nanette è uno speciale in piedi della comica tasmaniana Hannah Gadsby. (Fonte: YouTube)
La serie Netflix Nanette è uno speciale in piedi della comica tasmaniana Hannah Gadsby. (Fonte: YouTube)
Martedì sera tardi, il mio telefono ha suonato con un messaggio di testo di un caro amico: “Per favore, per favore, per favore, per favore guarda Nanette. È su Netflix”. Mi chiedevo perché mai, a quest’ora empia, il mio amico mi spingesse a guardare qualcosa che suonava, in mancanza di una parola migliore, antico? Ma poi ho ceduto e Nanette è apparsa sul mio schermo. Era uno speciale in piedi del comico della Tasmania, Hannah Gadsby. Come tutti i cabarettisti, Gadsby sale sul palco e inizia a fare una battuta. Niente di sconvolgente, si potrebbe aggiungere, a questo punto. Ma entro 15 minuti, lo spettacolo diventa più scuro.
Dopo aver parlato di bambini calvi e del “pool genetico spaventosamente piccolo” della Tasmania, racconta casualmente un aneddoto su un uomo in un bar che l’ha definita “frocio” e ha minacciato di picchiarla in poltiglia. Tuttavia, non lascia che questo indugi. Fa qualche altra battuta, e poi aggiunge che sta abbandonando la commedia perché come lesbica della Bible Belt australiana, ha costruito la sua reputazione sull’umorismo autoironico sulla sua lotta per uscire allo scoperto e si rifiuta di farlo più. E da qui, Nanette smette di essere solo un altro stand-up e diventa una radicale decostruzione della commedia. Martella sul punto che uno scherzo attraverso la sua stessa struttura – installazione e battuta finale – è enormemente inadeguato.
Verso la fine, con la quale Gadsby ha toccato e demolito tutto, dal privilegio di essere un maschio bianco eterosessuale, alla misoginia di Picasso, alla salute mentale, torna al primo aneddoto e racconta al pubblico di aver mentito al riguardo. L’uomo che l’ha definita “frocio” non l’ha minacciata, ma l’ha picchiata ripetutamente, perché era “diversa”. Che in un incidente precedente era stata anche violentata. E a questo punto il suo confronto diventa non tanto con la commedia, ma il pubblico, perché il pubblico per aspettarsi una risata, diventa anche in qualche modo spettatore muto, partecipe, della brutalità e dell’orrore quotidiano, normalizzandolo.
In Nanette Gadsby mostra che la commedia è insufficiente perché la struttura stessa di uno scherzo tralascia un elemento essenziale: le storie. “La risata”, dice Gadsby, “non è la nostra medicina. Le storie tengono la nostra cura.” E questo mi porta a una domanda schiacciante sull’India: qui, dove la brutalità e l’orrore quotidiano – che si tratti di aggressioni sessuali contro le donne, o l’emarginazione della nostra comunità LGBTQIA, o violenza contro le minoranze – sono tali segni distintivi della nazionalità, perché non t la nostra cabaret riflette questo? È abbastanza per le star dei fumetti accontentarsi di pubblicare meme sul loro account Instagram, video divertenti al limite con celebrità di Bollywood che a parole a favore dell’emancipazione delle donne, ignorando le domande sullo squilibrio di genere che affligge la loro stessa industria?
In altre parole, in questa fretta di scivolare dal setup alla battuta finale, perché mancano le storie reali sul nostro paese? E come pubblico, noi, nel non pretendere dai nostri fumetti che parlino del mondo reale, di storie vere, non siamo anche colpevoli nel non lasciare che queste storie vengano fuori? Perché quando decidiamo di nascondere le storie brutte e orribili sotto il tappeto, inviamo un tacito segnale che ciò che sta accadendo va più o meno bene. E una storia che non è stata raccontata può anche pretendere di esistere? Non stiamo quindi, volontariamente, come comunità, partecipando all’amnesia collettiva?
Potrebbe sembrare un po’ ingiusto individuare in questo modo il circuito del cabaret indiano, come se l’onere di raccontare storie che contano davvero dipendesse solo da loro. Mi permetta di spiegare. La cabaret – proprio come la letteratura, la pittura, la scultura, il cinema e il teatro – è un’arte, una performance. All’interno della struttura di un setup e di una battuta finale, il fumetto porta un vasto repertorio di personaggi. I personaggi possono far parte di un semplice scherzo Knock Knock, fino all’umorismo autoironico in cui il fumetto diventa un personaggio, all’umorismo situazionale che coinvolge uno o più set di personaggi in situazioni diverse. Nell’atto stesso di scrivere battute che compongono uno spettacolo, come un romanziere o un drammaturgo, il comico come autore è alla continua ricerca della verità, anche se quella verità è insieme multipla e subliminale.
I personaggi non hanno esistenza prima dell’atto stesso della scrittura, che si tratti di uno scherzo o di un romanzo. Ma una volta creato, come ci ricorda Harold Pinter nella sua famosa conferenza per il Nobel, l’autore cerca costantemente di recuperare nel tentativo di definire cosa siano realmente questi personaggi. In altre parole, un artista è sempre alla ricerca della verità, nei confronti dei suoi personaggi. Ma Pinter contrappone gli artisti a coloro che perseguono il potere, come i politici, il cui mondo è velato di bugie e inganni, perché la ricerca del potere significa che le persone dovrebbero rimanere ignoranti, “anche dalla verità della propria vita”. Ma l’arte ti fa dubitare della verità e di affrontarla.
Quindi, individuare i cabaret indiani non è tanto un tentativo di castigarli, ma esortarli a riconoscersi come artisti e come artisti per convincere il pubblico a confrontarsi con la verità, a parlare di questo tempo, il nostro tempo , non importa quanto brutto e orribile possa essere. Perché se gli artisti non abbracciano lo zeitgeist dei tempi, chi lo farà?


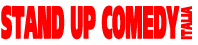

![non-ridere-[indianexpress]](https://standupcomedy.it/wp-content/uploads/2021/11/6352-non-ridere-indianexpress.jpg)

![prova-ed-errore-[indianexpress]](https://standupcomedy.it/wp-content/uploads/2021/11/6354-prova-ed-errore-indianexpress-150x150.jpg)
!['nessuna-commedia-qui,-niente-scherzi':-cabarettista-sulla-tragedia-della-miniera-di-meghalaya-[indianexpress]](https://standupcomedy.it/wp-content/uploads/2021/11/6350-nessuna-commedia-qui-niente-scherzi-cabarettista-sulla-tragedia-della-miniera-di-meghalaya-indianexpress-150x150.jpg)